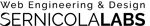La fabbrica di guanti
Cinema e Romanzi, Gianfranco Rebora, Pastorale americana, Philip Roth
“Le fabbriche di guanti, generalmente, sono state aziende a gestione familiare. Di padre in figlio. Aziende molto tradizionali. Per la maggior parte degli industriali, un prodotto è un prodotto. Chi lo produce non sa nulla del prodotto. L’industria guantaria non è così. Questa industria ha una lunga, lunghissima storia… Ci vogliono passione e tradizione per spingere qualcuno a rimanere in un settore industriale come questo”.
Pastorale americana, uno dei romanzi più noti di Philip Roth, il grande scrittore scomparso a marzo 2018, racconta l’intreccio tra la storia di questa fabbrica e la vita della famiglia che l’ha creata e gestita (edizione italiana: 1998, traduzione di Vincenzo Mantovani, Einaudi, Torino).
I personaggi chiave appartengono a quattro diverse generazioni di una famiglia ebrea, i Levov, il cui capostipite era immigrato dall’Europa intorno al 1890: “Tre generazioni. Tutte avevano fatto dei passi avanti. Quella che aveva lavorato. Quella che aveva risparmiato. Quella che aveva sfondato. Tre generazioni innamorate dell’America. Tre generazioni che volevano integrarsi con la gente che vi avevano trovato. E ora, con la quarta, tutto era finito in niente. La completa vandalizzazione del loro mondo”.
Tra loro spicca la figura dello ‘Svedese’ (un soprannome ricevuto in ambito scolastico), che il narratore ha conosciuto come compagno di scuola e sportivo di grande successo, poi soldato (volontario nei Marines nel 1945, ma senza la possibilità di combattere per la fine della guerra) e quindi manager e imprenditore vincente nell’azienda fondata dal padre.
Il suo vero nome è Seymour Levov e la sua vita esce dall’apparente linearità per rivelarsi molto più travagliata e sofferta per l’incapacità di affrontare il dramma conseguente al comportamento deviante e autodistruttivo della figlia Merry.
Roth tocca i vertici della sua forza espressiva nel proiettare l’irruzione del caos nella vita di una famiglia che sembrava incarnare gli ideali del sogno americano sullo sfondo della società statunitense degli Anni 60 e successivi, segnata dalle tensioni razziali, dai conflitti politici inerenti la Guerra del Vietnam e dai mutamenti portati dall’ormai imminente globalizzazione dell’economia.
Ne viene illuminato soprattutto il carattere critico del passaggio dalla complessità tecnica, che lo Svedese aveva dominato nello sport, nei Marines e nell’azienda, a quella relazionale: “L’uomo bello e buono con il suo modo indulgente di affrontare il conflitto e la contraddizione, l’ex atleta sicuro di sé ragionevole e pieno di risorse in ogni lotta con un avversario leale, si trova a doversi misurare con un avversario che leale non è – il male inestirpabile delle relazioni umane – ed è spacciato”.
Il concetto di ‘pastorale americana’ dovrebbe rappresentare un discorso di unità e di mutuo riconoscimento tra diversi, quale è simboleggiato dalla Festa del Ringraziamento, quando “tutti mangiano le stesse cose”, “un tacchino colossale per 250 milioni di persone”, che “le sazia tutte”: “Una moratoria su ogni doglianza e su ogni risentimento […] per tutti coloro che, in America, diffidano l’uno dell’altro. È la pastorale americana per eccellenza e dura 24 ore”.
Il dramma dei Levov, padre e figlio, consiste nella scoperta traumatica che “il vecchio sistema per mantenere l’ordine non funziona più”, che la lotta contro il disordine, contro l’eterno problema dell’errore e dell’insufficienza dell’uomo” è destinata alla sconfitta; anche “fabbricare superbi guanti da donna di ogni misura” non garantisce “la costruzione di una vita tale da andare a pennello a tutti coloro che amava”.
È il loro stesso congiunto, Jerry Levov, che in un concitato dialogo telefonico con il fratello mette il dito nella piaga: “Sai cos’è un guanto, cazzo. Ecco l’unica cosa che sai. […] Una famiglia tiranneggiata dai guanti, bastonata dai guanti, l’unica cosa che conti nella vita: guanti da donna!”.
Una lettura del romanzo attenta ai temi dell’impresa può trovare molteplici spunti di interesse, quali tra gli altri la storia della fondazione, la successione al vertice dell’azienda e le contraddizioni della responsabilità sociale.
L’articolo completo è pubblicato sul numero di Novembre-Dicembre 2018 di Sviluppo&Organizzazione.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)